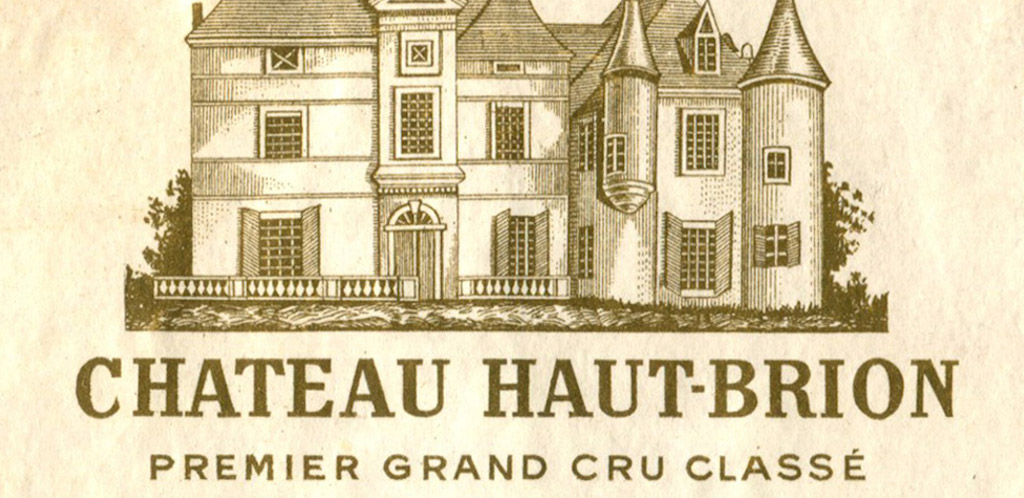Bacco giramondo – Continua il viaggio elvetico tra degustazioni e bei paesaggi: è la volta di Argovia, Berna, Basilea e Lucerna
Stupefacente è l’avanzata dei produttori di vino nella Svizzera tedesca! La passione che questi uomini e donne hanno messo nella vinificazione e nella ricerca, da qualche anno, ha portato a produrre dei crus veramente straordinari, con cui vincono concorsi e guadagnano medaglie.
Il vigneto «svizzero tedesco» ingloba tutte le regioni germanofone, vale a dire la Svizzera orientale, centrale e occidentale, su una superficie che copre sedici cantoni molto differenti tra loro per clima e suolo; da notare inoltre che in media le aziende vitivinicole sono piuttosto piccole (2-4 ettari per unità). Per semplificare, partiremo dalla regione occidentale.
Tenuto conto della superficie consacrata alla vite e della produzione di vino, i due cantoni più importanti sono Argovia e Berna. Basilea (Campagna-Città) occupa una posizione intermedia, seguono Lucerna e Soletta, dove la viticoltura è quasi domestica (3,5 ettari vitati), 45% vino bianco e 65% rosso.
I viticoltori del canton Argovia sono senza dubbio dotati di grande audacia e iniziativa con i loro 90 ha vitati; il vigneto argoviese è situato in gran parte a nord ovest del cantone tra Rheinfelden e Aarau, sulle rive destre dell’Aar e a nord est della Limmat.
Tra i comuni viticoli più importanti, dove bisogna assolutamente scoprire le cantine-bistrot gestite dagli stessi produttori, troviamo Döttingen, Klingnau, Würenlingen, Tegerfelden, Ennetbaden. Oltre ai classici Pinot Noir / Blauburgunder e al Riesling x Sylvaner, vengono coltivati una trentina di altre qualità, tra nuovi e vecchi vitigni. Notevoli certe cuvées speciali a base di Cabernet Sauvignon, Malbec con Pinot Noir, e Pinot Noir con Diolinoir elevati in barrique, come certi vini bianchi davvero stupendi. Tra le novità si annoverano specialità inabituali alle nostre latitudini come il Zweigelt (apprezzato in Austria); il Dornfelder; il Gewürtztraminer che ci entusiasma con i suoi aromi delicati e possenti; il Kerner e il Scheurebe, anch’essi appartenenti alla stessa famiglia dei vitigni bianchi aromatici, ma più discreti; e infine il Bacchus, vitigno bianco dai sentori di noce moscata (lo abbiamo provato in versione metodo classico, ottimo). Nel nostro girovagare tra i vari produttori abbiamo degustato anche degli eccellenti Chardonnay, dei Grauburgunder (Pinot Grigio) e dei Sauvignon Blanc. Con le tecniche di congelamento delle uve, abbiamo pure provato dei vini passiti molto interessanti come il Muscat Oliver, gustato a Ueken con la classica Rüeblitorte (torta di carote).
Sulle rive de lago di Bienne nel canton Berna, i vini sia bianchi sia rossi sono molto simili ai loro cugini di Neuchâtel. Noi ci siamo fermati nella superba regione del Lago di Thun (14 ha), dove abbiamo visitato il bellissimo vigneto di Spiez con il suo castello, così come quello di Oberhofen, arroccato sul pendio a strapiombo sul lago, dove abbiamo degustato un’eccellente Riesling x Sylvaner e un Pinot Noir, in una cornice degna di una cartolina.
Il vigneto di Basilea Campagna è il solo della Svizzera tedesca a produrre dei Chasselas (Gutedel), leggeri, nervosi e con una buona acidità, ma è solo una piccola produzione dei 106 ha vitati: qui la parte del leone la fa il Pinot Noir, dove la maturazione beneficia del rialzo delle temperatura portata dai caldi venti della valle del Reno.
Nei villaggi di Muttenz e Liestal ai confini con l’Alsazia, i terreni più argillosi influenzano molto la struttura dei vini prodotti. Particolari i Gewürtztraminer e i Riesling x Sylvaner molto aromatici; curiosi i vini prodotti come Vin de Glace; e meritevoli il Räuschling e il Garanoir.
A Dornach e Prattelni produttori discepoli del biologico, coltivano di preferenza ibridi interspecifici, perché resistenti alle malattie, i vini prodotti meritano di essere degustati. Questi i vitigni: Seyval Blanc per i bianchi, Regent, Maréchal Foch e Léon Millot per i rossi. Non bisogna lasciare il cantone senza aver visitato i 5 ha di vigneti, orgoglio di Basilea Città, arroccati in modo spettacolare sulle pendici del Schlipf a Riehen, dove ci lega il ricordo di un piatto di rognoni flambée abbinato a un Pinot Noir di 4 anni maturato in barrique di quercia svizzera.
Il vigneto del Canton Lucerna ha una superficie viticola di poco superiore ai 16 ha, con una produzione di ca. 150mila bottiglie, 20 i comuni viticoli e circa altrettanti i vignerons-produttori professionisti che gestiscono almeno 1 ha di vigna, dove 1/3 sono coltivati a vitigni a bacca bianca e 2/3 in rosso.
I vignerons, per i loro vigneti , sfruttano i terreni dei luoghi privilegiati sulle rive del Lago dei Quattro Cantoni nel Seetal e il Wiggertal, nei comuni di Kastanienbaum e Horw, ai picchi del Bürgenstock, i suoli morenici ben drenati, il riverbero del lago e il favonio, assicurano alle uve un’ottima maturazione, con una gradazione Oechsle che abitualmente si situa tra gli 85° e 90°. Ça va sans dire che i vini lucernesi sono rari, cari, ma di grande qualità: per poterli conoscere bisogna acquistarli presso i produttori o scoprirli in qualche ristorante «top» del Cantone. I vini bianchi sono prodotti principalmente con il Riesling, il Riesling x Sylvaner, il Pinot Blanc e lo Chardonnay, tra i rossi il Pinot Noir, il Garanoir, il Diolinoir, il Regent.
Ricordo indelebile, il Sauvignon dai profumi di sambuco bevuto in un hotel di Lucerna ad accompagnare un piatto di asparagi al burro.
/ Davide Comoli