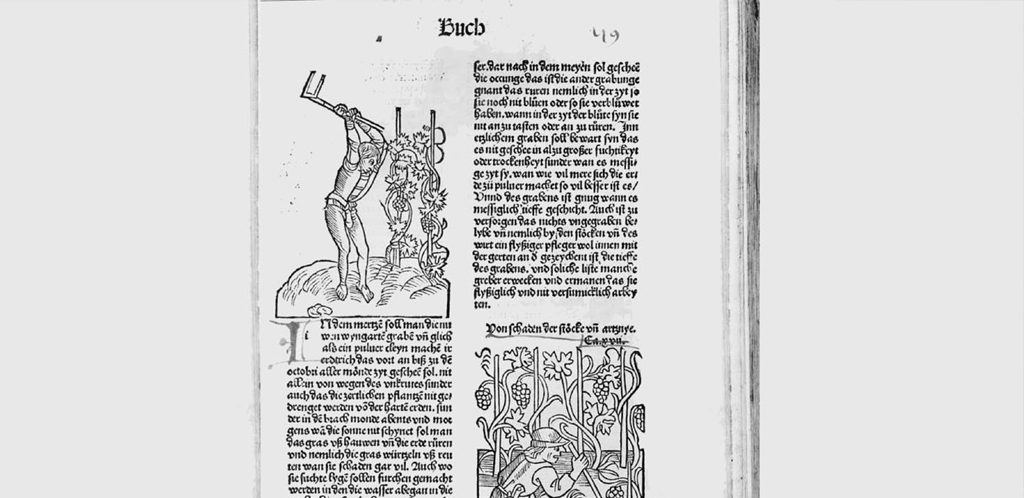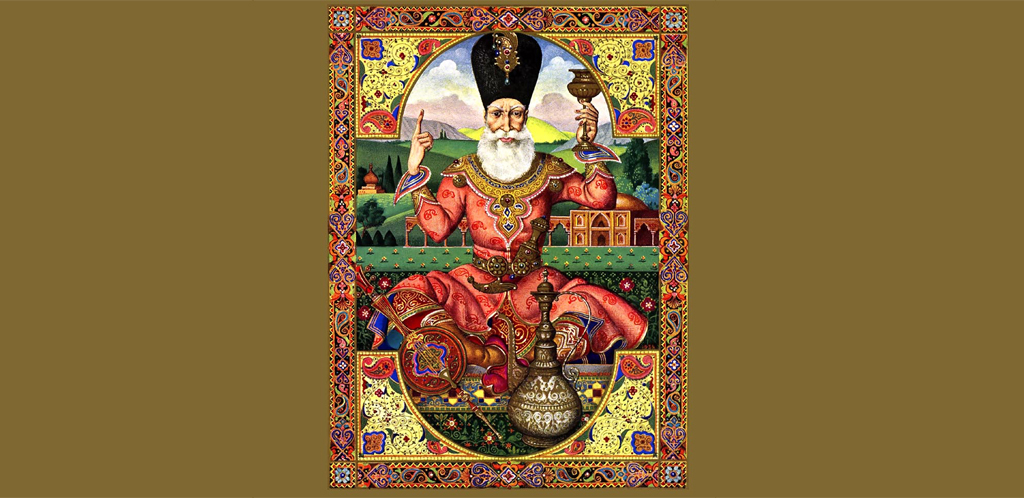Bacco Giramondo – Continua il viaggio nella Lombardia vitivinicola
La produzione vinicola della Lombardia non è certo importante come in altre regioni d’Italia, ma in questa area geografica che è la Franciacorta, formata da piccoli colli e ampie vallate situate a sud del lago d’Iseo (l’antico Sebino) e a est della provincia di Bergamo, ha saputo ritagliarsi un importante spazio internazionale nel mondo vitivinicolo grazie a un vivace dinamismo. Il «miracolo» Franciacorta è il risultato ottenuto grazie alla lungimiranza di produttori seri e motivati, dotati di grande energia, ma soprattutto innovazione. Inoltre il visitare i vigneti sparsi tra i vari villaggi, il degustare i vini nelle innumerevoli cantine situate talvolta all’interno di storici edifici, ci portano a rivivere le origini magistralmente raccontate da Gabriele Archetti nel suo Le origini della Franciacorta nel Rinascimento Italiano.
Noi la «storia» delle bollicine della Franciacorta la troviamo nelle Cantine Guido Berlucchi a Borgonato di Corte Franca, con Paolo Ziliani che davanti la mitica «numero uno» imbottigliata nel 1961, ci racconta come è nato il mito Franciacorta, prima di passare a una indimenticabile e conviviale degustazione dei vari Brut, Rosé, Satèn e infine ai Millesimati.
Il nostro itinerario continua in direzione di Brescia, dove costeggiando le colline, s’incontrano dei gruppi rocciosi che fan da corona al capoluogo di provincia. Sui ridenti colli intorno a Gussago, dove i terreni sono composti da un misto calcareo-argilloso con mescolanze di fanghiglie ereditate da diverse epoche geologiche, troviamo la D.O.C. Cellatica che produce vini rossi di buona sapidità e struttura dai vitigni Barbera, Schiava, Marzemino, Sangiovese e Incrocio Terzi (incrocio tra Barbera e Cabernet Franc). Sono vini ottenuti da uvaggi tra i vitigni sopracitati, da bersi abbastanza giovani che accompagnano piatti semplici durante le scampagnate in collina.
A sud di Brescia potete trovare la D.O.C. Capriano del Colle, dove vengono prodotti interessanti vini bianchi, elaborati dal Trebbiano di Soave e un passito ottenuto dal semisconosciuto vitigno Invernenga.
Scendendo verso il lago di Garda, tra i comuni Rezzato e Botticino, troviamo la D.O.C. Botticino, dove gli stessi vitigni rossi di cui abbiamo accennato, grazie al fortunato matrimonio con il terreno argillo-calcareo, talvolta marnoso, danno origine a vini dai profumi vinosi, intensi, caldi e giustamente tannici, il completamento ideale per una veloce merenda con salumeria e formaggi mediamente stagionati.
La strada che ci porta verso Desenzano del Garda, ci ricorda che fin dai tempi antichi, grazie alla barriera delle Dolomiti che frenano i freddi venti, al lago di Garda veniva dato l’appellativo di «lago benefico» (Benacus), tant’è che le sue rive furono luogo di soggiorno per personaggi del calibro di Plinio, Virgilio, Strabone, Catullo.
L’area collinare compresa tra Desenzano e Salò, tappezzata da ulivi e vigneti prende il nome di Valtènesi, orgoglio della zona è il Garda Classico Chiaretto, ottenuto da uve Groppello, Sangiovese, Barbera, caratterizzato dal colore rosato, dai profumi di rosa, viole, fragoline di bosco e lamponi; molto interessante è anche il rosso Garda Groppello, ottenuto da vitigno omonimo con il piccolo aiuto di Marzemino e Barbera, dotato da intriganti profumi floreali e fruttati.
Da Desenzano, riprendiamo la S236 in direzione di Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova, cittadina dall’illustre passato, per ritornare verso Solferino. Questo circuito a sud del Garda è formato da cordoni collinari concentrici. La sua posizione ne ha fatto nel corso della storia un territorio punteggiato da strutture difensive. Dal punto di vista enologico siamo nella D.O.C. interregionale del Garda, dove si producono vini di pronta beva, ottimi per allegri convivi. La sera ci trova nei pressi di San Martino della Battaglia, uno dei luoghi simboli del Risorgimento italiano, un ottimo Lugana (qui chiamato Turbiana) e un piacevole Marzemino leggermente frizzante.
Al mattino di buon’ora imbocchiamo l’A4 posta a 1,5 km e alla periferia di Brescia entriamo sulla A21 dove usciamo a Stradella, siamo nell’Oltrepò Pavese. Questa è una terra generosa, ricca di una vasta gamma di vitigni, capace di produrre vini bianchi fermi, spumanti secchi e dolci, vini rossi sia da bere giovani sia da invecchiamento.
Da Stradella prendiamo la SS10 e raggiungiamo Broni passando per l’antica via Emilia, consigliamo questa cittadina come punto di partenza per un giro tra i vigneti dell’Oltrepò. A sud-ovest, immerso in un paesaggio collinare, dove i crinali sono coperti dalla vite, si arriva a Canneto Pavese, che con Montescano, Castana e Pietra de’ Giorgi, è la patria del Buttafuoco (Barbera, Croatina e Ughetta), lo stesso uvaggio impiegato per il dolce e frizzante Sangue di Giuda.
Dalla provinciale che costeggia la riva sinistra del torrente Versa, circondato da filari di viti, si raggiunte Montù Beccaria, le varie diramazioni ci portano a Santa Maria la Versa, considerata la capitale dello spumante sia metodo classico che Martinotti, usando i vitigni Chardonnay, Pinot Grigio, Riesling Italico, Riesling Renano, che oltre a esaltare le note fruttate e la loro freschezza, riescono a dare ai vini un’importante nota minerale, il Moscato Bianco, con cui si producono vini dolci, dalle note aromatiche.
Una grande attenzione viene data al Pinot Nero a Santa Giuletta, in questa zona viene sfruttato tutto il potenziale di questo vitigno (Oltrepò ne è il maggior produttore italiano), per produrre rossi fermi d’invecchiamento, di grande eleganza, dai profumi di liquirizia. Notevole il metodo classico a cui è dato il curioso nome di Cruasé, ottenuto con macerazione a contatto con le bucce, è uno spumante dal colore rosa salmone, con suadenti sfumature di fragoline, melograno e arance sanguinella, che abbiamo abbinato a delle succulente «tartine con salmone affumicato, formaggio di capra e rondelle di cipolla» che aromaticità; senza dimenticare «da ultimo ma non ultimo», una bottiglia del vero simbolo enologico di questa terra, la Bonarda (Croatina), tipologia ferma, dal profumo di viole, abbinata a uno «stufato di lepre», che vino!
Attraversiamo il Po nei pressi di San Zenone al Po, ci siamo diretti verso San Colombano al Lambro, unica D.O.C. in provincia di Milano, dove sulle colline argillose si coltivano gli stessi vitigni dell’Oltrepò, che ne tappezzano la superficie sino a Miradolo Terme. È ispirandosi a questi luoghi che il Francesco Redi (1626-1697) scrisse i seguenti versi, che di fronte alla distesa di vigneti prepotentemente ci tornano in mente: «il purpureo liquor del suo bel colle, / cui bacia il Lambro il piede, / ed a cui Colombano il nome diede, / ove le viti in lascivetti intrichi / sposate sono invece d’olmi a’ fichi.».
/ Davide Comoli