Bacco giramondo – Continua il viaggio nelle regioni d’Italia, dividendo in due la terra delle città medioevali e della Riviera adriatica – Prima parte
Regione cerniera tra l’Italia continentale e quella peninsulare, l’Emilia Romagna si apre a nord verso la «Bassa» Padana e accompagna il fiume Po verso la sua foce: la via Emilia divide questa parte dal versante sud e più orientale, dove la Romagna viene bagnata dal Mare Adriatico.
Nata nel 1860 sulle ceneri dei ducati di Parma e Piacenza, di Modena e Reggio, di Ferrara e delle terre che lo Stato Pontificio possedeva a nord di Roma, questa regione vanta zone molto differenti tra loro, tipologie e vitigni diversi, tradizioni che alle volte sembrano molto distanti l’una dall’altra, tutte sfumature mantenute grazie anche al fatto che sia gli emiliani sia i romagnoli tengono molto alla loro identità. In rispetto, dunque, a queste differenze, il dividere la regione in due articoli separati ci sembra cosa logica, e partiremo dall’Emilia solo per scelta casuale.
L’archeologia colloca la coltura della vite in questa regione molto indietro nel tempo: reperti dell’età del bronzo (1700 a.C.) rimandano gli albori della viticoltura a quell’epoca. Ma come testimonia lo scrittore latino Varrone, furono gli Etruschi a far compiere un salto di qualità alla coltivazione delle viti in questa zona, portando nuovi vitigni nonché adeguate tecniche produttive.
Sta di fatto che quando il console romano Marco Emilio Lepido nel 187 a.C. fece costruire la via consolare Emilia, di certo constatò con ammirazione la successione di vigne e l’abbondanza di vino. Non per nulla, autori latini scrivevano di questa regione lodandone l’eccezionale produzione fino a 312 hl/ha! Sebbene nessuna fonte si domandi se tanta abbondanza corrispondesse ad altrettanta qualità.
Tra il XIII e il XIV secolo, compaiono il Trebbiano, che a detta di Pier de’ Crescenzi «fa nobile vino e ben serbatojo» e la Malvasia; nel XVII secolo compare anche il Lambrusco, come figlio delle viti menzionate da Catone, il quale avrà un successo strepitoso. Il XIX secolo vede invece la crisi fillosserica che distruggerà il 90 per cento dei vitigni della regione.
Lungo la direttrice della Via Emilia, scendendo verso sud, si attraversano le provincie emiliane – con l’eccezione della provincia di Ferrara, situata poco più a nord-est: ebbene il vigneto emiliano si estende per circa 28mila ettari.
La parte nord-occidentale è quella dei Colli Piacentini e, percorrendo la Strada dei Vini, sembra di entrare in una fiaba fra castelli, borghi e pievi, sulle valli Tidone, Trebbia, Nure e Arda. Qui il vino più rappresentativo è senz’altro il Gutturnio (Barbera e Croatina), un rosso di buon corpo, simile ai rossi dell’Oltrepò Pavese, d’abbinare con tipici Pisarei e fasò. Accanto a lui troviamo un bianco leggero e talvolta frizzante, l’Ortrugo, prodotto da uve omonime, da provare con i ravioli burro e salvia, senza dimenticare i profumati e gustosi salumi piacentini.
Proseguendo il nostro itinerario incontriamo l’incantevole Castellarquato, castelli da sogno e dolci colline ricoperte di vigneti, ci fermiamo in Val Trebbia per un ristoro dell’anima nell’Abbazia di San Colombano a Bobbio. Gustiamo qui il Trebbiano e a Monterosso Val d’Arda una profumatissima Malvasia di Candia, Moscato, Trebbiano e Ortrugo. Scendendo verso Parma, fate una sosta a Vigoleno, dove si produce una chicca enologica come il Vin Santo di Vigoleno, in cui entrano pure vitigni come il Sauvignon e la Marsanne.
Proseguendo per Parma, la viticoltura si concentra nelle zone pedecollinari, dove il Sauvignon è il vitigno più rappresentativo e i vitigni coltivati fanno pendant con quelli sopraccitati. Abbiamo poi apprezzato molto lo Spumante Metodo Classico prodotto con uve Pinot Nero, Chardonnay e Pinot Bianco, gradevolissimo aperitivo, quando ci siamo fermati nel Parco Regionale nell’area compresa tra i fiumi Taro e Ceno, dove paesaggi rurali incoronano prodotti agroalimentari di assoluta eccellenza (prosciutto di Parma, salame felino, tartufo nero di Fragno e naturalmente il parmigiano reggiano).
Varcando il confine della provincia di Reggio Emilia si entra nel regno dei vini frizzanti: qualche chilometro prima del capoluogo inizia l’area del Lambrusco, tra Montecchio, Gualtieri, Cavriago e comuni limitrofi, si produce il Reggiano Lambrusco Salamino, gradevole e fresco, forse il più leggero e beverino fra tutti gli altri Lambruschi. Salendo lungo le pendici dell’Appennino troviamo Bibbiano e raggiungiamo Canossa, con i ruderi del castello di Matilde. Bagnati da un frizzante e leggero Bianco di Scandiano, prodotto con uve Sauvignon (qui chiamato Spergola), abbiamo gustato il «Gnocco fritto» e «l’Erbazzone», una torta salata a base di Parmigiano Reggiano DOP ed erbette.
Il nostro viaggio ci porta a visitare le acetaie dell’aceto balsamico tradizionale di Modena DOP e a entrare nelle cantine dove si vinificano le diverse varietà di Lambrusco. Il più famoso è molto probabilmente il Lambrusco di Sorbara, ma quelli con più corpo e violacei sono il Lambrusco Salamino di Santa Croce e il Lambrusco di Castelvetro, sono questi dei vini semplici che affondano le radici nella più autentica tradizione popolare della provincia di Modena.
Poco prima di Bologna facciamo una deviazione verso nord-est in direzione della provincia di Ferrara, verso la fascia di costa tra il delta del Po e la foce del Reno, unica zona della provincia a vantare una produzione vitivinicola, caratterizzata dalla coltivazione di vitigni che crescono bene sui terreni sabbiosi. Il vitigno più famoso è il Fortana, le cui origini potrebbero risalire alla civiltà etrusca che aveva fondato la civiltà di Spina. I vigneti di costa, allevati su dossi sabbiosi, tra i boschi di lecci con viti basse, hanno resistito al flagello della fillossera, e sono infatti a «pied franc», senza portainnesto americano.
La DOC Bosco Eliceo Bianco e Bosco Eliceo Rosso, è prodotta con uve Fortana, Merlot, Trebbiano e Sauvignon. Sono vini unici nel loro genere; assolutamente da provare in una delle tante trattorie della valle di Comacchio, è il Bosco Eliceo Rosso con «l’anguilla alla brace».
Chiude il panorama della vitivinicoltura dell’Emilia una zona completamente diversa da quelle precedenti. Il nostro viaggio continua, infatti, in provincia di Bologna, percorrendo la strada dei Colli Bolognesi. L’inizio dei vigneti di Sangiovese ci fa capire che siamo vicini alla Romagna: piccoli gioiellini enologici si trovano cammin facendo tra i crinali e le vallate appena fuori Bologna, fino ai confini della Toscana.
Tra i vitigni cosiddetti internazionali ritroviamo anche il Barbera e un Bianco prodotto con uve Albana, sebbene il più caratteristico sia senza dubbio quello prodotto con le uve Pignoletto, utilizzato anche per la produzione di vini frizzanti e spumanti, leggeri e particolarmente piacevoli. Consigliamo comunque di provare il Pignoletto Classico DOCG, vino morbido e sapido, per accompagnare un piatto di «Tagliatelle di castagne con pancetta e pecorino».
Il nostro viaggio continuerà sul prossimo numero dedicato alla rubrica «Bacco giramondo» verso la Romagna, regione che dal punto di vista vitivinicolo non ha nulla da spartire con l’Emilia.
Scelto per voi

Gamay Gilliard
Con il suo colore violaceo, una sostenuta acidità e tannini abbastanza leggeri, morbido che quasi vi strega, il Gamay della maison Gilliard di Sion dona un vino dalla stupefacente intensità olfattiva, dove predominano il cassis, la ciliegia e, tra i profumi floreali, la violetta.
Vitigno di origine borgognona, il Gamay ha subito trovato il suo habitat ideale sui terreni granitici del Vallese, dove la natura s’avvicina molto ai terreni del Beaujolais-Villages e trova i suoi terroirs ideali tra Martigny e Saillon.
Facile da bere, per il suo tasso alcolico ragionevole, il Gamay va bevuto giovane e, per la sua natura fruttata, lo raccomandiamo con piatti di salumeria, carni bianche cucinate in modi diversi e piatti di formaggio. Nella stagione fredda lo abbiamo provato con una fondue chinoise: una meraviglia.
/ Davide Comoli






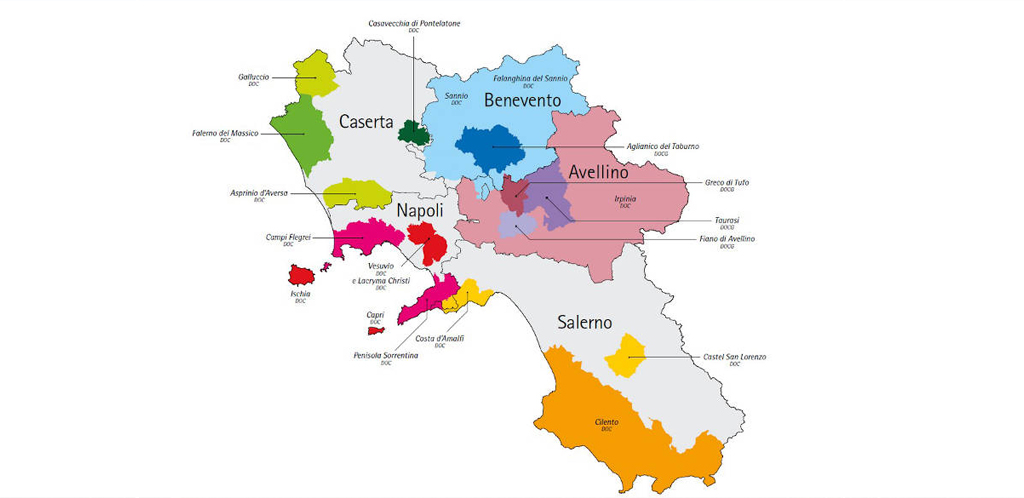


 Sauvignon
Sauvignon
 Scalandrino – Vermentino
Scalandrino – Vermentino
 Triade
Triade
 Pinot Grigio Felluga
Pinot Grigio Felluga
 Barbera d’Alba Superiore «Adriano»
Barbera d’Alba Superiore «Adriano»